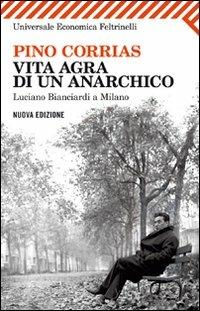E' un po' complicato scrivere questa recensione su “Corpi minori”, secondo romanzo di Jonathan Bazzi, astro nascente della narrativa italiana, celebratissimo dopo lo splendido (a me piacque davvero tanto) esordio, “Febbre”.
Quando scrissi la recensione di “Febbre” ebbi l'impressione che il suo allora editore, Fandango, non avesse ben capito la bomba che aveva tra le mani e, nel tentativo (giusto a livello commerciale) di dargli maggiori pezze di appoggio, avesse puntato a presentarlo come un libro in cui si parlava anche della condizione contemporanea di qualcuno che ha fatto coming out come sieropositivo.
In verità, come ormai ben sappiamo, quel libro parlava di altro: una giovane vita con una sensibilità altissima e un certo personale grado di inquietudine ed eclitticità immersa in un contesto familiare e periferico che di sensibile ed eclettico non aveva niente.
Ho come la sensazione che anche “Corpi minori” sia un libro presentato (in realtà in questo caso anche pensato) con un certo tema di fondo, ma che in realtà sarebbe stato molto più efficace e sincero se si fosse accorto di parlare di altro.
Sin dall'incipit che dal titolo che dalla frase scelta su retro della copertina, si evince che l'idea di fondo sia quella di presentare una sorta di educazione sentimentale dell'autore/protagonista (essendo, anche questo un memoir) nei confronti della persona amata e nei confronti di Milano.
In verità, il libro, a mio parere è una grande occasione persa per parlare di qualcosa che affiora e si prende continuamente la scena, in qualsiasi momento, e che divora le varie storie sentimentali e i molti discorsi in cui l'autore si aggroviglia.
Dico questo, subito, perché a me piace moltissimo come scrive Bazzi, ma non quando usa molti lunghi periodi circonvoluti per giustificare azioni discutibili agli occhi del lettore.
Non sta alla narrativa essere accomodante, ma se ti esponi al giudizio poi non è scontato che io riesca a empatizzare perché qui e lì scodelli qualche lunga dissertazione sui corpi desideranti.
I corpi desideranti non sono comunque autorizzati a fagocitare le esistenze altrui.
Ma andiamo un po' oltre, perché su questo, tornerò. Il vero tema del libro, quello che si prende la scena è evidentemente MILANO.
Milano è una città difficile da capire per chi non l'ha vissuta, come in verità tutte le città.
Ma soprattutto è una città difficile da capire per chi non l'ha vissuta senza avere soldi o una famiglia dietro.
Lo dico con la massima cognizione di ogni causa. Quando andai al nord, avevo letteralmente 500 euro in tasca, senza aiuti, e ho vissuto numerose situazioni picaresche che ho rivisto con una certa dose di empatia nel libro di Bazzi.
Premetto. Non ho mai subaffittato niente a nessuno né mi sono mai permessa cose che il mio ignobile stipendio di molti anni non mi abbia concesso di fare. Lo sottolineo perché Milano è una città incredibilmente diversa, e sottolineo INCREDIBILMENTE, per chi ha e non ha i soldi.
Non è solo questione di affitto, è questione di opportunità.
Assai più di qualsiasi città italiana, Milano è un posto dove qualcuno di brillante, pur non essendo necessariamente figlio di qualcuno, può farcela. Questo non significa che sia un paradiso meritocratico, anzi, l'alta borghesia riserva sempre le giuste quantità di posti di lavoro sopra una certa RAL ai propri rampolli. Lo fa in tutti i settori, dal commercio all'editoria, dalle multinazionali al mondo culturale.
Diciamo che, vuoi perché comunque si percepisce che i povery talentuosi possano essere un valore aggiunto, vuoi che ci sia ancora adesso una disponibilità lavorativa assai più elevata del resto d'Italia, ci sono molte variabili impazzite. Io, lo ammetto sono stata una di queste (ho svolto un lavoro che mai pensavo nella vita, ovviamente con un RAL da povera perché poi bisognerebbe anche aprire una discussione su questo, ma non qui).
La variabile impazzita però non può essere presa come regola e cancellare tutte le persone che, non potendosi permettere stage non pagati e master esosi, si trovano a fare lavori malpagati vivendo in posti indecenti (ci ho vissuto anche io), affittati a prezzi da strozzini da gente o fondi immobiliari che posseggono interi palazzi.
Non può far dimenticare il fatto che a Milano paghi tutto e paghi tutto tanto e che questo, mi spiace, non sia giustificato da niente. Io sono anni che sono inferocita con l'idea delle gabbie salariali perché non c'è nessun motivo per cui uno stipendio del nord debba valere più di quello del sud solo perché al nord si specula con maggior follia.
Per qualche motivo però ha deciso che no, il suo sarebbe stato un romanzo d'amore in cui spiegava una cosa in verità non molto interessante: ho un fidanzato bramatissimo, ma a un certo punto mi sembra di non amarlo più, cerco di capire perché, in qualche modo lo capisco (anche se nel libro onestamente non è molto chiaro cosa succeda a tal proposito) e via come se non fosse mai successo niente.
Non voglio essere brutale e non mi permetto di giudicare l'interiorità e il vissuto di Bazzi, ma analizzo il modo in cui l'ha raccontato e in cui l'ho percepito.
Il racconto sull'emotività dell'autore, onestamente, non è che abbia fatto grande breccia nel mio animo. La freddezza con cui liquida il povero primo fidanzato che lo mantiene per anni, il modo feroce col quale giudica praticamente tutti coloro che incontra, tentando di capire quasi sempre come sfruttarlo al momento a suo vantaggio, il suo vagare per università proposto come inquietudine di vita e morale non è che sia proprio la lettura più digeribile del mondo.
Il libro mostra un autore che in parte, ripeto, si espone al giudizio altrui senza farsi sconti, ma in parte sembra nascondere un approccio incredibilmente egoriferito dietro a contorti concetti filosofici rubati qui e lì da insegnanti e autrici. Una citazione di De Monticelli o Stein è inutile se il libro non riesce andare oltre a una superficie e questo desiderio tra essere e apparire esplode anche a livello universitario.
Posso studiare alla Statale, ma perché non andare al San Raffaele? La scuola dei ricchi milanesi, simbolo e status?
Il problema, in generale, di tutto il libro, secondo me si esplicita proprio lì.
Bazzi non sembra avere non dico una coscienza politica o di classe, perché mi rendo conto che sono termini desueti, ma una coscienza del fatto che provenire da un ambiente sociale considerato minore è una percezione che introiettiamo dagli altri, ma quando esci dall'adolescenza, deve smetterla di essere un tuo problema.
Non c'è nulla da dimostrare, nessun simulacro a cui aggrapparsi, nessuna università cool da frequentare, nessun circolo di poetesse che fanno yoga e sussurrano alle orecchie, o credulerie sulla cabbala assieme a Paola e Chiara a cui aggrapparsi.
La Milano di adesso si basa tanto su questo equivoco: l'idea che maggiore è lo splendore sociale che puoi dimostrare, maggiore sarà il tuo valore.
Quindi la laurea vale di più se è privata, sei più giusto se fai un lavoro fighissimo pagato una miseria e non il commesso da Zara con uno stipendio da CCNL del commercio, lo psicologo che ti cura è bravo solo se lo paghi tanto.
Non c'è valore oggettivo della persona, c'è il valore che quella persona può mettere sul piatto perché tutti lo ammirino. Partendo da questo presupposto, è ovvio che non si possa mai uscire dall'idea che comunque i natali te li ha dati la temibile Rozzano.
Ed è proprio per questo motivo, credo, immagino, Bazzi non sia riuscito a scrivere un racconto picaresco sulla Milano brillante e feroce di adesso. Un enorme circo dove puoi ambire a tutto, ma il tuo valore è deciso, se non dalla famiglia, dal cash, e se non dal cash dai posti che frequenti, le persone che conosci, i circoli esclusivi dove bazzichi.
Ed è, sottolineo, un'epica oscura della città che ha radici profonde.Se si legge Bianciardi, Milano è sempre stata così: pronta a ingoiare i suoi abitanti non integrati, a succhiarne lo spirito dopo avergli offerto opportunità che altrove sarebbero impossibili. Non puoi vivere da nessun'altra parte, ma se ci vivi, se non stai molto attento, ne vieni spolpato.
Ma Bianciardi aveva una coscienza di sé, di ciò che era rispetto a Milano, del rancore e della riconoscenza che le portava, del dolore che questa città gli infliggeva e della riconoscenza che le doveva, che Bazzi non sembra neanche lontanamente contemplare.
Milano è il posto dei sogni, un parco giochi che però caspita costa e allora troviamo un pollo a cui affibbiare quasi tutto l'affitto, della scuola privata da fare anche senza i soldi per farla, della voglia di viverci, ma di lavorare anche no, di mollare l'affitto non pagato ai coinquilini e di schifarli pure anni dopo.
Cosa c'è oltre al corpo desiderante che desidera e fagocita e pretende e fagocita in nome di un passato di svantaggio che pone in perenne condizione di risarcimento sociale?
Cosa c'è oltre alla citazione filosofica, se poi la città (e quello che ti fa) non riesci a vederla?
Mi spiace, ma il libro, pur scritto davvero bene, per me è un'occasione mancata. Il memoir è un genere che dovrebbe andare oltre alla pirandelliana visione della realtà, raccontarci qualcosa anche di noi, cosa che in "Febbre" succedeva.
In "Corpi minori", personalmente, questa astrazione almeno io non l'ho avuta e, onestamente, le recensioni basate sullo sguardo borghese che gioisce del giovane autore che viene dalla periferia (consiglierei sul tema la lettura di quel capolavoro che sono le pochissime pagine autobiografiche di Scerbanenco), mi sembrano solo una conferma della mia sensazione generale.