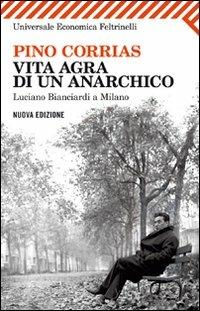Come ho scritto molte volte, ho una certa passione per le storie delle case reali nata in tenera età non per una qualche tendenza assurdamente monarchica, ma a causa dei "Gente" che leggevo da mia nonna.
Per qualche motivo che indubbiamente un buono psicologo saprebbe spiegare, durante la pandemia avevo trovato una nuova declinazione delle mie passioni reali, a uso instagram: le storie dei gioielli delle casate regnanti.
Io sono una che nella vita mette addosso giusto la fede e un su coccu, ma di colpo, sotto gli strali del Covid, quando come tanti non riuscivo a dormire, mi sono scoperta appassionata di tiare, diamanti a taglio cuscino e cabochon.
Quello che mi affascinava era il fatto che dietro a tali gioielli ci fossero spesso storie intricatissime che di solito facevano capo a una qualche dinastia in disgrazia che, al culmine dell'infelicità e povertà, doveva disfarsi dei suoi gioielli (non sempre, qualche volta, raramente, c'erano storie di matrimoni felici).
Tutto ciò mi ha portato involontariamente a contatto con uno strano mondo: quello degli appassionati di gioielli reali e di reali.
Visto l'argomento forse dovevo anche aspettarmelo, ma ho scoperto che tendenzialmente queste persone non erano come me, ossia non consideravano la monarchia un pezzo d'antiquariato della storia straordinariamente pervicace e colmo di storie interessanti.
No, loro ai monarchici erano appassionati anche politicamente, cioè credevano autenticamente che fosse una valida forma di governo mettere in mano il potere a un primogenito casuale.
Appassionati, ma prevalentemente appassionatE visto che la maggior parte erano donne.
Non ero comunque lì per giudicare, ma per apprendere quando una tiara potesse dirsi kokoshnik e quando no.
Tuttavia ben presto ho capito che tra questi gruppi di appassionat3 reali c'erano delle convinzioni e delle simpatie e antipatie granitiche nei confronti di alcune figure.
Ovviamente tutte amavano Elisabetta la Queen e su questo ci siamo. Praticamente quando è morta Elisabetta era diventata una cara nonnina che piaceva pure ai sassi.
Poi venivano però cose più elaborate. Ad esempio Letizia di Spagna pare sia considerata antipaticissima, colei che ha fatto litigare l'affascinante principe Felipe (che non si spiegano davvero come abbia potuto sposarla) e il suo adorato cugino Pavlos, un nobile senza corona che vaga per le corti europee con moglie americana e milionaria al seguito. Ecco, su Letizia enorme croce sopra: è troppo borghese, poco elegante, scortese con la suocera (vera maestra di grazia, soprattutto nel gestire le corna).
Molto amata è ovviamente la fu Grace Kelly, ma la sua nuora Charlene, altra controversa principessa, non è ben compresa e per risolvere la situazione, visto che Alberto non è charmant come Felipe, pare che la soluzione sia non ritenere il Principato di Monaco un regno vero e proprio, quindi insomma, se pure non hanno una principessa vera e propria un po' chissene (e comunque è meglio Caroline perché ha avuto il buon gusto di sposare un Hannover e diventare SAR).
Tutte cose che insomma mi stupivano, ma fino a un certo punto.
Quello che però davvero a un certo punto mi ha fatto strabiliare sono stati la trascinante passione e l'adorante trasporto nei confronti di Carlo d'Inghilterra, un personaggio che nella mia vita ho sempre visto considerare debole e fondamentalmente inadatto al ruolo.
Preciso di non aver mai avuto una passione per Diana, (non ho mai avuto la passione per nessun reale), ed è morta quando ero ancora troppo giovane per capire le dinamiche di una coppia abbastanza complessa e sotto pressione, ma insomma, la storia di Carlo che la sposa per avere dei figli e intanto tiene stretta l'eterna amante al suo fianco, beh me la ricordavo bene.
Comunque, mi sono detta, de gustibus non disputandum est. La bellezza non è tutto e che Carlo abbia un certo ascendente su gente che passa le sue giornate a disquisire di spille vittoriane non deve stupirmi, l'eccezione sono io. Il re è re e i monarchici amano i re, è lapalissiano.
Però. Leggendo commenti e post alla fine ho capito una cosa: stavano riscrivendo la storia, o meglio, stavano scrivendo una loro convinta versione della storia recente dei reali inglesi.
In questa versione della storia, Carlo è un re in potenza meraviglioso, ecologista, moderno, ricco di idee e di charme. Purtroppo la lunga vita della sempre amata Elisabetta gli ha impedito finora di dimostrarlo, ma presto farà vedere a tutti di che pasta è fatto. Accanto avrà l'amata Camilla, su cui devo dire non si spendono mai particolari parole, (si tende a omettere che abbia dei figli ad esempio), se non che lo sostiene e lo ama come lui ha bisogno.
Vabbeh, mi sono detta, alla fine tutti i rospi diventano principi a un certo punto, soprattutto quando alla fine hanno una corona in testa.
La sorpresa però è stato il trattamento riservato a Diana.
Dell'amore a lei riservato alla sua morte e durante la sua breve vita non vi è traccia. Il meglio che possono dire, ma solo perché nonostante tutto non si può proprio negare, è che sia almeno stata una "madre esemplare".
Per il resto è una cascata di: Diana era fragile, una personalità problematica, soffriva di una spasmodica ricerca di attenzioni, aveva bisogno di aiuto, aveva tradito il povero Carlo con mille amanti (pare che il fatto che Carlo ne abbia avuto una fissa annulli l'adulterio, pure se sei il capo della chiesa anglicana).
Insomma, usano tanti giri di parole, ma fondamentalmente, gira che ti rigira, il concetto è che era una pazza.
Ho pensato varie volte se replicare che dare della pazza a una morta e sepolta da tempo e incapace di difendersi fosse il caso, ma è molto tempo che sono stufa di litigare su internet e ho sempre evitato di turbare i sonni di queste sciure e sciuri.
Questi giorni però è uscito "The Crown 5" e ovviamente mi sono fiondata a vederlo.
Ebbene. La narrazione dei royal appassionat3 che leggevo su Instagram nelle serate pandemiche è diventata LA narrazione mainstream. Carlo è impersonato da un attore affascinante, charmant, sicuro di sé, una proiezione mistica di una persona che non è mai stata, ma che ora, essendo sul trono, evidentemente viene riscritta e sovrascritta.
Siamo oltre ai dipinti migliorativi dei sovrani tramandati nei secoli, siamo al dipinto migliorativo in presa diretta.
Nella fiction, Carlo diventa un homo novus, liberandosi di timidezze e incertezze dopo il divorzio con Diana (la regina dice proprio che sembra si sia "liberato"). Una teoria che risulta poco credibile anche se volessimo considerare "The Crown" come uno script senza fondamento reale visto che nella serie precedente il giovane Carlo (la cui gioventù arriva fino ai 40 anni almeno) è completamente diverso e dopotutto è stato sposato con Diana per tempo relativamente breve.
Diana, ovviamente, non essendoci più una controparte altrettanto problematica a giustificarne le azioni (come avveniva nella quarta serie) viene quindi dipinta come una mezza pazza dagli occhioni sempre sgranati, l'innamoramento compulsivo, la tristezza in tasca e nessuna ragione per essere paranoica.
Camilla appare, opportunamente senza figli e senza marito, silenziosa e sorridente, a fianco del futuro consorte, pronto a sostenerlo.
Quello che ho letto su Instagram è ora lì sullo schermo.
Sono rimasta discretamente sconcertata, ma poi, come accade spesso, la letteratura mi è venuta in aiuto. Io questa cosa l'avevo già letta e l'avete letta anche voi.
Questa non è la trama della storia di Carlo, Diana e Camilla, questo è l'impianto sentimentale della trama di "Jane Eyre", preciso preciso.
Nel libro, la bella, brava, buona e giusto un filino ribelle Jane conosce il presunto vedovo Mr Rochester che vive nel suo bel maniero nella brughiera.
Rochester ha un segreto e quel segreto è il motivo per cui non può sposarsi: ha una prima moglie che tiene in soffitta. La donna, un tempo bellissima, che ha sposato in Giamaica dopo averla vista appena una manciata di volte, è diventata pazza e incontrollabile e lui è costretto a tenerla in soffitta, guardata a vista da un'infermiera.
Rochester definisce così il loro matrimonio:
"Fui abbagliato, i miei sensi furono eccitati, ed inesperto com'ero credei d'amarla.
Non vi è nulla che trascini un uomo quanto le stupide rivalità della società, i desideri febbrili, l'accecamento giovanile. I parenti di Berta mi incoraggiavano, i competitori mi eccitavano l'amor proprio, lei stessa mi attirava a sé e così il matrimonio fu concluso prima che avessi tempo di riflettere. Quando penso a quell'atto non posso davvero stimarmi! Il disprezzo di me stesso mi assale e mi tortura!
Non l'amavo, né stimavo e non avevo potuto conoscerla."
Nonostante ciò, la donna, Bertha, è violenta, tenta di scappare e commette atti inconsulti, non ultimo il fatale incendio finale dove, molto opportunamente, perirà lasciando Rochester ferito, ma libero finalmente di sposarsi con la donna che ama.
Il collegamento con Jane però non mi è venuto grazie a un mio (inesistente) amore per la letteratura inglese.
Semplicemente vedendo "The Crown 5" e la pessima scrittura della povera Diana mi è tornato alla mente il titolo di un libro che avevo visto citato nella nota di un qualche saggio femminista che avevo letto durante i primi anni di università.
Il titolo era "The madwoman in the attic": la pazza nella soffitta.
Si tratta di un saggio di critica femminista sulla narrativa vittoriana scritto da Sandra Gilbert e Susan Gubar nel 1966.
Le due critiche descrivevano la polarizzazione, nella narrativa vittoriana opera di autrici donne, di due sole tipologie di personaggi femminili: l'angelo e il mostro, in contrapposizione tra loro.Una dicotomia funzionale ovviamente alla stereotipata visione femminile in un contesto patriarcale di cui le autrici, benché donne, non erano riuscite a liberarsi.
Ma del resto sembra che non siano riusciti a farlo neanche gli autori di "The Crown" quasi 150 anni dopo.
Diana è diventata la matta nella soffitta, sposata per sbaglio e perenne ingombro tra il Principe e il suo vero amore.
Camilla è un angelo, certo, un angelo stiracchiato, ma che con un po' di omissioni può essere considerato passabile in nome del suo amore imperituro e purificatore per il principe.
E così "The Crown" ha incontrato le royal narrazioni uso instagram che hanno incontrato Jane Eyre e che, fondamentalmente, ricalcano uno schema talmente già visto che neanche ce ne accorgiamo.
Il potere sa come dipingersi al suo meglio e la tendenza a dimenticare con estrema facilità degli esseri umani fa il resto.
Così per una favoletta revisionista che imbelletti il nuovo re con regina consorte è bastato meno del previsto, del resto le donne sono ancora angeli o mostri, a seconda di come conviene al momento.
La trama vittoriana regge ancora. Le mogli sposate per sbaglio muoiono ancora bruciate nella soffitta dei ricordi e i re regnano felici sul loro trono, come se non fossero mai esistite.